|
|
È noto che io dispongo di un sito
personale di fotografia, linkato alla pagina gallerie.
Potreste quindi domandarvi per qual motivo ho chiesto ospitalità al
Rollei Club per trattare un argomento che nulla sembra avere da
spartire con la Rollei poiché, a parte le compatte, a pellicola o
digitali, non mi risulta che la produzione classica sia mai stata
equipaggiata con obbiettivi a focale variabile.
La risposta è semplicissima: ho voluto introdurre in modo un po’
provocatorio le mie considerazioni, di cui anticipo la conclusione. Un
apparecchio che il fotoamatore evoluto può utilizzare con
soddisfazione può avere un solo obbiettivo o, se consente la
sostituzione dell’ottica, può essere equipaggiato con una focale base
da usare per il 95% degli scatti e un’altra o al massimo altre due,
per i casi estremi.
Questa affermazione sembra smentita dalla proliferazione di obbiettivi
a focale variabile, che equipaggiano sia compatte, sia reflex di
fascia bassa, sia reflex di fascia alta. Non voglio davvero
rispolverare la leggenda metropolitana per cui un obbiettivo a focale
fissa ha una resa migliore dello zoom poiché le differenze possono
venire solo dalla classe (vulgo prezzo) e non già dallo schema ottico.
Ancora la variazione della luminosità in funzione della lunghezza
focale è stata eliminata negli zoom di fascia medio alta, il cui costo
non è poi spaventoso, specie se paragonato a certi mostri sacri. Anche
il peso non fa grande differenza se lo zoom viene utilizzato in luogo
di tre o quattro ottiche fisse.
Ma qui occorre intenderci.
La differenza tra il fotoamatore e il fotografo professionale non sta
nella diversa attrezzatura utilizzata: anch’io nel mio piccolo potrei
equipaggiare due o tre professionisti e conservarmi materiale a
sufficienza per la gita domenicale e anche per la vacanza estiva.
Ma il fotoamatore scatta solo se l’attrezzatura di cui dispone gli
consente di realizzare l’immagine che ha previsualizzato e se tenta
ugualmente qualche risultato improbabile ha sempre la riserva mentale
di gettare via la creatura deforme.
Il professionista la foto la deve fare in quel momento e in quelle
condizioni e deve ottenere un risultato decente e presentabile.
Per lui non vale la regola che il migliore zoom sono i piedi poiché
non sempre può spostarsi e non è agevole cambiare l’obbiettivo in
mezzo ad una folla vociante o durante una cerimonia i cui tempi sono
rigorosamente prefissati.
E poi ci sono quelli che concepiscono la fotografia solo come
strumento per conservare i ricordi ed è bene che essi abbiano vita
facile, in attesa di compiere il grande salto alla ricerca di quel che
ci appaga perché bello di per sé e non per la tenerezza che viene dal
sorriso di un bimbo.
Per queste due categorie di utenti hanno una precisa ragion d’essere
gli obbiettivi a focale variabile, la cui resa sia stata
opportunamente calcolata in funzione dei risultati voluti e della
spesa che è giusto affrontare per raggiungerli.
Ma la scelta della distanza dal soggetto è un fattore essenziale per
la composizione dell’immagine, sotto il duplice profilo della
prospettiva e del fuoco selettivo, e a questi fini l’uso di un
obbiettivo a focale variabile, che ci consente semplicemente di
riempire il quadro senza modificare la distanza dal soggetto,
lasciando al caso (o meglio a precise regole matematiche delle quali
peraltro non ci curiamo di tener conto) la resa prospettica e la
profondità di campo, equivale ad una rinuncia alla composizione di
un’immagine nostra.
Una convincente dimostrazione del mio assunto si trova alla pag. 205
di quel bellissimo libro, interessante non solo per gli appassionati
del marchio Leica M (confesso, lo sono anch’io, pur se si tratta di
una passione meditata ed utilitaristica e non già di un legame
affettivo profondo come per la Rollei) di Gunther Osterloh.
Le sei immagini ivi riportate dimostrano che:
a) con la sostituzione di tre ottiche, di 21, 50 e 135
mm, la prospettiva di una foto scattata alla stessa distanza non
cambia;
b) con la sostituzione delle stesse ottiche e con la variazione della
distanza fra l’apparecchio di presa e il soggetto, in modo da
mantenere o comunque variare appena il quadro, la prospettiva
cambia completamente nel senso che il primissimo piano viene
fortemente evidenziato o appiattito rispetto a quelli più distanti;
c) anche se questo non era lo scopo dell’autore, risulta palese che
con l’avvicinamento e l’allontanamento dell’apparecchio rispetto al
soggetto la profondità di campo (a parità di diaframma, ma non credo
che vi siano state variazioni, trattandosi per sempre di foto scattate
in sequenza, in buone condizioni di illuminazione e quindi con un
tempo di posa adeguato anche per la focale più lunga), varia
notevolmente.
Sulla base di questi dati verifichiamo ora le possibilità offerte da
una Rollei biottica con focale da 75 o 80 mm.
L’angolo di campo va dai 52° di un Planar 2,8 ai 57° di uno Xenotar o
Xenar 3,5, i paragonabile a quello di un 40 mm che copra il
formato 24 x 36. Tenuto conto che non è difficile realizzare un
ingrandimento di cm 40 x40 da una porzione di fotogramma impressionato
con obbiettivo Rollei intorno ai mm. 20x20, la stessa ottica si
comporta come un 135 mm su un 24x36 ingrandito senza tagli a 50X70.
In pratica i piedi del fotografo possono utilizzare una rollei come
uno zoom da 40 a 135 mm per quel che riguarda le possibilità
d’ingrandimento ad un formato da esposizione.
Un diverso discorso si deve svolgere per quanto attiene alla
possibilità di intervenire sulla prospettiva e sul fuoco selettivo.
E qui mi ricollego a quel che Roberto Mirandola scrive sul Bollettino
n. 4, a proposito del Rolleikin, nel senso che il mero ingrandimento
di una porzione del fotogramma 6x6 non influisce sulla prospettiva
fino a rendere l’effetto di un medio tele, mentre con l’uso di quell’accessorio
l’effetto in discorso si verifica senz’altro sul fotogramma 24x36.
Il rilievo è esatto, ma per ottenere lo stesso risultato non è
necessario montare il Rolleikin e la pellicola da 35 mm: è sufficiente
installare la sola mascherina sul vetro smerigliato o sulla cornice
del traguardo, in modo da considerare il campo ripreso grazie
all’arretramento come un normale fotogramma 24x36, anche se di fatto
sulla pellicola troveremo un’immagine ben più ampia.
In altre parole, per ottenere l’effetto grandangolo o tele, in modo da
allontanare reciprocamente il primo piano da quelli successivi o
schiacciarli fra di loro, è sufficiente prefigurarsi l’immagine che ci
appare sullo schermo quale risulterà in concreto, se il primo piano
viene a riempire tutto lo schermo, quando si siamo avvicinati, o ne
occupa
solo una parte, quando ci siamo allontanati.
Sia chiaro però che se anche spingiamo l’ingrandimento oltre i limiti
di un ideale fotogramma 24x36, l’effetto sulla prospettiva sarà di un
medio tele da 75 o 80 mm e non di più.
Quanto alla profondità di campo, è evidente che essa rimane per
ragioni geometriche quella di un obbiettivo da 75 – 80 mm. Essa,
invariato il diaframma, aumenta man mano che ci allontaniamo dal
soggetto per ottenere un effetto tele sulla prospettiva o diminuisce
man mano che ci avviciniamo per ottenere un effetto grandangolo.
Dovrete quindi giocare sul diaframma e sul tempo di posa per ottenere
tutto a fuoco o una sfocatura armoniosa.
Certo non potrete realizzare quegli effetti, un po’ abusati se non
interpretati con un granello di sale, del girasole che riempie un
quarto del fotogramma e domina sul prato giallo e sulla collina
sormontata da un filare di cipressi. Per questi occorre un 15 mm (e ve
ne parlerò se Roberto vorrà darmi ospitalità per uno scritto sulla
nuova Bessa Voigtlander .. .. Cosina, mamma povera della Rollei 35
RF), ma qualcosa si può ottenere, mettendo a profitto la praticaccia e
giocando su distanza, diaframma, iperfocale, altezza da terra, e ciò lavorando
anzitutto con il cuore, un poco con la testa, molto
con i piedi e abbastanza con le ginocchia e la schiena.
Non vi propongo fotografie da me scattate che possano convalidare il
mio assunto poiché per abitudine tendo sempre a riempire completamente
il fotogramma 6 x 6 e se gioco sulla prospettiva avvicinandomi o
allontanandomi da quello che considero un elemento principale, tendo a
inserire tale effetto in un ambito che conserva un autonomo valore al
quadro globale.
Può darsi che, dopo la confessione di qualche scappatella con la Leica
o con la Bessa vi venga la curiosità di sapere se anche in questi casi
sono così legato alle mie opinioni da fare uso di un solo obbiettivo.
Ovviamente non è così: non rinuncio alle possibilità che mi vengono
offerte dal sistema; tengo sull’apparecchio un 35 mm e mi porto di
scorta un 90 mm e, in qualche caso, un 28 o magari un 20 o 15 mm. Ma
quasi sempre il Summicron 35 asferico o anche il vecchio e insuperato
Summaron 35/3,5 risultano all’altezza del risultato che voglio
ottenere.
Altair
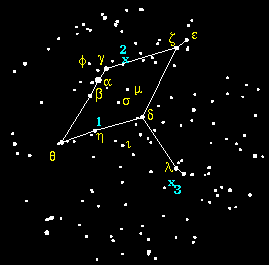
Torna a Opinioni
* * * *
|